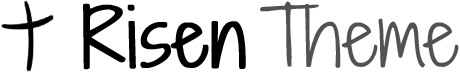(Marco 4:35-40)
In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all’altra riva». E lasciata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che noi moriamo?». Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?».
Dopo aver annunciato ai discepoli e alle folle alcune parabole da una barca appena scostata dalla spiaggia:
Mc 4:1 Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno a lui. Perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva.
- Vs 21 Poi diceva ancora: La lampada sul candeliere
- Vs 26 Diceva ancora: Il seme che da sé germoglia e cresce
- Vs 30 Diceva ancora: Il granello di senape
Il capitolo 4, è un capitolo molto ricco del Vangelo: è dove si concentrano la maggior parte delle parabole di tutto il libro.
Le parabole non offrono soltanto informazioni sul regno di Dio, ma formano il cuore dei discepoli ad accoglierne la logica paradossale. Il loro linguaggio semplice e penetrante consente di accogliere lo scandalo della croce per poi aprirsi alla gioia della risurrezione.
Un altro dato che si registra leggendo Marco è la grande quantità di miracoli: nove miracoli di guarigione, cinque miracoli nei confronti della natura, quattro esorcismi e sei sommari di miracoli.
La distribuzione dei racconti dei miracoli permette poi di riconoscere una composizione mirata. Nella prima metà del vangelo (1,1–8,26) ricorrono quindici racconti di miracoli, nella seconda metà (8,27–16,8) soltanto tre.
La concentrazione dei primi miracoli (1,21-28.29-31.40-45) subito dopo la discesa dello Spirito Santo su Gesù, le tentazioni e l’annuncio del Regno orienta l’interpretazione: nei miracoli di Gesù il Regno si è reso presente.
Con la rivelazione di Cesarea di Filippo la strategia di Gesù cambia: nel suo cammino con i discepoli verso la croce (8,31–10,52) e Gerusalemme (11,1–16,20) sono narrati soltanto tre miracoli, e precisamente un esorcismo, la guarigione del cieco Bartimeo e l’essiccazione del fico. Nella seconda parte del vangelo la teologia dei miracoli cede il passo alla teologia della croce.
Tra i maggiori atti straordinari attribuiti a Gesù ci sono anche i miracoli che intervengono sul corso della natura. Marco ne riporta cinque, tra cui quello di cui parliamo oggi.
Gesù decide di passare all’altra riva del mare di Galilea: si tratta di un’“uscita” dalla terra santa di Israele, per andare verso una terra abitata dai pagani. Perché questa decisione così audace?
Perché Gesù, pur sentendosi “inviato prima alle pecore perdute della casa di Israele” (cf. Mt 15,24), vuole annunciare la misericordia di Dio anche alle genti, vuole combattere Satana e togliergli terreno anche in quella terra straniera e non santa. Questa è la ragione che muove Gesù.
Giona, chiamato da Dio ad andare a Ninive, città simbolo delle genti pagane, fugge, fa un cammino in direzione opposta (cf. Gn 1,1-3); Gesù invece, inviato da Dio, va tra i pagani.
I discepoli, dunque, iniziano la traversata del lago, “prendendo con sé Gesù” (espressione unica, perché di solito è Gesù che prende con sé i discepoli: cf. Mc 9,2; 10,32; 14,33).
E’ importante ricordare che per gli ebrei il mare era il grande nemico, vinto dal Signore quando fece uscire il suo popolo dall’Egitto (cf. Es 14,15-31); era la residenza del Leviatan, il mostro marino (cf. Gb 3,8; Sal 74,14); era il grande abisso che, quando scatenava la sua forza, impauriva i naviganti (cf. Sal 107,23-27).
Ed ecco che la potenza del demonio si manifesta in una tempesta di vento, che getta le onde nella barca e tenta di affondarla. È notte, è l’ora delle tenebre, e la paura scuote quei discepoli, che non riescono più a governare la barca.
“Lailaps”, parola greca dal suono esotico, perfino dolce, che sembra evocare serenità, ha una propria suadente musicalità. In realtà significa tutt’altro: è il vocabolo usato per “tempesta”.
Ma mica una tempestina, lo troviamo anche nel libro di Giobbe nella sua traduzione greca dei LXX quando Dio gli parla “dal seno della tempesta”. Ricordate la tempesta di Giobbe? Una serie di disgrazie sconvolgenti, perdita di affetti, salute, beni … .
Avete mai affrontato una traversata, lunga o breve che fosse, con il mare agitato?
Un mare in tempesta, il vento che soffia impetuoso, le onde spumeggianti, gli schizzi che ti bagnano la faccia e soprattutto quella sensazione di disagio, di incertezza, di insicurezza.
Certamente le navi moderne offrono standard di sicurezza elevati ma quella linea dell’orizzonte inclinata ti dice un’altra cosa: ti dice che nulla è stabile, che ogni elemento della vita si muove, ondeggia, oscilla.
Niente tiene: un lutto, una malattia, relazioni che terminano, la nostra identità stessa che sentiamo minacciata quando cambia qualcosa: cambia il lavoro, andiamo in pensione … la linea dell’orizzonte non è stabile.
La tempesta evocata dal racconto marciano ha inoltre una caratteristica peculiare: é improvvisa e violenta, questo perché le tempeste del lago di Tiberiade sorgevano repentinamente a causa dell’incontro tra i venti del Mediterraneo e quelli provenienti dal deserto siriano.
Un attimo prima la quiete, un attimo dopo la tempesta. Suona familiare no?
Torniamo sulla barca di Gesù, le barche dei pescatori di allora non erano certo il massimo della sicurezza, lunghe 7-8 metri, avevano un solo albero ed una sola vela, governarle non era facile, in particolare in caso di maltempo, infatti si tendeva a navigare non lontano dalla riva e solo con buone condizioni meteo.
Pensiamo allora a come vedere entrare l’acqua in una barca del genere riempisse di terrore gli occupanti.
Gesù cosa fa? Dorme. Noi vediamo la nostra barca riempirsi di acqua ed il Signore dorme? Siamo sicuri che dorma? Chi è al timone? E quando la barca della nostra vita si riempie di acqua cosa proviamo?
A volte neghiamo quanto accade: non é possibile che la mia barca rischi di affondare. Altre volte ci arrabbiamo: perché proprio a me? E quante volte ci arrabbiamo con Dio per quello che ci capita. I discepoli fanno lo stesso, anzi, lo rimproverano: Non ti importa che noi moriamo? La frase é dura, é un’accusa.
I discepoli sono in preda all’angoscia vedono Gesù addormentato e si spazientiscono. Decidono dunque di svegliarlo e, con modi non certo reverenziali, gridano: “Maestro, non t’importa nulla che siamo perduti?”.
Già questo modo di esprimersi è eloquente: lo chiamano maestro (didáskalos) e con parole brusche contestano la sua inerzia, il suo sonno.
Parole che nella versione di Matteo diventeranno una preghiera – “Signore (Kýrios), salvaci, siamo perduti!” (Mt 8,25) – e in quella di Luca una chiamata – “Maestro, maestro (epistátes), noi periamo!” (Lc 8,24) –. Marco ricorda meglio i rapporti semplici e diretti, finanche poco gentili, dei discepoli verso Gesù…
Cosa significa che Gesù dorme allora? Che lui dorma è una percezione, un’impressione che possiamo avere quando le onde della vita incombono, ma non possiamo mai dimenticare che il Signore è innanzitutto un Dio di misericordia, difatti Gesù interviene: sgrida il vento, dice al mare : “Taci, calmati”.
Ma se noi vedessimo uno in piedi su una barca, in mezzo al mare, gridare controvento una frase del genere, cosa penseremmo? E’ pazzo. Grida inutilmente. Cosa significa? Significa che il Signore non agisce come magari ci aspetteremmo. Un marinaio che farebbe? Tenterebbe di ammainare la vela , afferrerebbe il timone. Lui fa altro. Lui parla … ed ordina “Taci”.
Esattamente quanto Gesù dice anche nel primo capitolo di Marco all’indemoniato: “Taci ed esci da lui”. Vediamo quindi unire fatti della vita dolorosi -tempeste- e le loro
conseguenze fatte di sofferenza interiore. Mali esteriori e interiori sono insieme … e Gesù vi si oppone. Dio si oppone. “Taci, adesso basta, stai cheto ora, stai calmo”, è la reazione di Cristo ad ogni disordine che ci sconvolge la vita.
Gesù parla a noi, si occupa dei nostri dolori, non è lontano, è sulla barca, esattamente con noi. Gesù è sulla barca, non è a riva, non è nella sua casa a Cafarnao, è in mezzo alla tempesta, come noi, e lo è fino alla croce.
Parlare nella Bibbia è un fatto, la parola compie sempre qualcosa, non è mai solo una chiacchiera. Il “taci” è un fatto, è il Signore che agisce e la sua azione ha sempre un effetto.
In Isaia 55:11: “Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio”. Il mare infatti si calma, arriva una “gran bonaccia”.
Anche qui, non solamente il vento che si calma o il sereno che torna, letteralmente il Vangelo parla di “gran bonaccia”; la bonaccia è lo stato di quiete assoluta, quando il mare non è increspato da alcuna onda, quando non un alito di vento si solleva, nessuna brezza, solo … quiete. Il termine greco tradotto come bonaccia si può tradurre anche come pace, calma, quiete interiore, serenità.
Questo miracolo operato da Gesù – non sfugge a nessuno – ha soprattutto una grande portata simbolica, perché ognuno di noi nella propria vita conosce ore di tempesta. Anche la chiesa, la comunità dei discepoli, a volte si trova in situazioni di
contraddizione tali da sentirsi immersa in acque agitate, in mari mossi, in un vortice che minaccia la sua esistenza.
In queste situazioni, in particolare quando durano a lungo, si ha l’impressione che l’invisibilità di Dio sia in realtà un suo dormire, un non vedere, un non sentire le grida e i gemiti di chi si lamenta.
Sì, la poca fede fa gridare ai credenti: “Dio dove sei? Perché dormi? Perché non intervieni?” (cf. Sal 35,23; 44,24; 59,6, ecc.).
Dobbiamo confessarlo: anche se magari crediamo di avere una fede matura, di essere cristiani adulti, nella prova interroghiamo Dio sulla sua presenza, arriviamo anche a contestarlo e talvolta a dubitare della sua capacità di essere un Salvatore.
La sofferenza, l’angoscia, la paura, la minaccia recata alla nostra esistenza personale o comunitaria ci rendono simili ai discepoli sulla barca della tempesta.
Per questo Gesù li deve rimproverare con parole dure. Non solo chiede loro: “Perché siete cosi paurosi?”, ma aggiunge anche: “Non avete ancora la fede?”. Discepoli senza fede, senza adesione a Gesù: lo seguono, lo ascoltano, ma non mettono in lui piena fiducia…
Ed ecco che di fronte a queste parole così critiche di Gesù, ma anche di fronte al prodigio che hanno visto con i loro occhi, affiora nei discepoli una domanda:
“Chi è veramente questo rabbi, questo maestro, se anche il vento e il mare gli sono sottomessi?”.
Eppure anche da questo evento non sapranno trarre una lezione, perché, quando giungerà per Gesù e per loro la grande tempesta, l’ora della sua passione e morte, verranno meno a causa della loro mancanza di fede.
Di fatto, questa prova della tempesta sul mare è annuncio della grande prova che li attende a Gerusalemme; ma allora tutti lo abbandoneranno e fuggiranno (cf. Mc 14,50)….
Poi di fronte a Gesù morto e sepolto, verificheranno un grande fallimento del maestro e del loro gruppo. E solo la tomba vuota e il contemplare Gesù vivente, risorto da morte, genereranno in loro una fede salda, che li porterà a confessare Gesù quale vincitore sul male e sulla morte.
Allora, in quanto testimoni del Risorto, diventeranno anche capaci di affrontare, a loro volta, la tempesta che si abbatterà su di loro: la persecuzione a causa del nome di Gesù e della fede in lui.
Quando Marco scriveva il suo vangelo e lo consegnava alla chiesa di Roma, la piccola comunità cristiana nella capitale dell’impero era nella tempesta e regnava in essa una grande paura, tale da impedire a quei cristiani la missione presso i pagani.
Così Marco li invita a non temere l’“uscita” missionaria, li invita a conoscere le prove che li attendono come necessarie (cf. Mc 10,30); prove e persecuzioni nelle quali Gesù, il Vivente, non dorme, ma è in mezzo a loro.
La tempesta sul mare di Galilea è una metafora della lotta contro le potenze del male, lotta che Gesù Cristo ha vinto.
Le nostre tempeste ci lasciano sgomenti, ci sentiamo sballottati dalle onde, spesso di fronte ai problemi o alle difficoltà li rifiutiamo, o anche ci fanno arrabbiare – o siamo assaliti dalla depressione, ci sentiamo soli … ma c’è anche un’altra possibilità che è quella della bonaccia, della pace che il Signore ci vuole donare, che con le sue parole, che nella Parola, in ogni modo, anche con il brano di oggi, ci vuole trasmettere e lo fa interpellandoci.
Un Gesù che infatti dopo ci dice: “Ma come? Non hai fiducia in me ?”.
La fede cui il testo di Marco si riferisce è proprio intesa come fiducia in Gesù, nelle sue parole, nella sua azione, invitandoci a non avere paura ad avere fiducia in lui perché il Signore è sulla barca con noi ed opera.
Il miracolo è il segno concreto di ciò che Gesù è per l’uomo: colui che salva totalmente,spiritualmente, fisicamente. In Marco si ha l’impressione che, se la fede produce i miracoli, non sempre i miracoli producono la fede.
Tutto questo ha un centro propulsore e una motivazione: la venuta del Regno che è entrato nella storia.
Quanto è cristiana la frase: “Naufragium feci, bene navigavi”! “Ho fatto naufragio, ma ho navigato bene”, perché sono approdato nel regno di Dio.