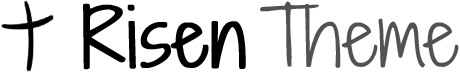Matteo al cap. 18: 21-35
“Allora Pietro si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte?» E Gesù a lui: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo: “Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto”. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò un altro servo come lui che gli dovevacento denari; e, afferratolo, lo strangolava, dicendo: “Paga quello che devi!” Perciò quel servo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me, e ti pagherò”. Ma l’altro non volle; anzi andò e lo fece imprigionare, finché avesse pagato il debito. Gli altri servi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l’accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché tu mi hai supplicato; non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?” E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
Insegnando a pregare ai suoi discepoli con la preghiera del Padre nostro, Gesù aveva consegnato loro anche queste parole: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6,12). E aveva ancora aggiunto: “Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 6,14-
15). L’insegnamento è chiaro: la richiesta di perdono a Dio è credibile se accompagnata dalla disponibilità e dalla concreta pratica del perdono fraterno. Analogo insegnamento è presente anche nella liturgia giudaica che afferma che nel giorno dell’espiazione e del perdono (Yom Kippur), vengono perdonati solo i peccati commessi contro Dio, mentre per le trasgressioni commesse tra uomo e uomo “Yom Kippur procura il perdono solo se uno prima si è rappacificato con il proprio fratello” (Mishnà, Yomà 8,9). La parabola presente nel brano del vangelo letto rappresenta una esegesi esemplare di tale insegnamento.
E’ il quarto dei cinque grandi discorsi di Gesù nel vangelo secondo Matteo, detto anche discorso ecclesiale o comunitario, perché in esso sono contenuti insegnamenti riguardanti la vita dei discepoli viventi in comunità, nelle chiese. Viene innanzitutto riferito il contesto dell’insegnamento di Gesù contenuto nella sua parabola. Avendo egli enunciato le esigenze della correzione fraterna e del perdono reciproco (cf. Mt 18,15-20), Pietro solleva una questione alla quale Gesù risponde subito in modo perentorio, ma poi rivela “in proposito” (diá toûto) cosa accade nel regno dei cieli, quale comportamento l’azione di Dio ispira ai discepoli. Questa pagina è un insegnamento decisivo nella vita ecclesiale, e dobbiamo confessare che noi cristiani la leggiamo spesso e volentieri, ma poi non riusciamo a metterla in pratica quando siamo coinvolti in dinamiche analoghe.
Matteo è l’evangelista che, più degli altri, dedica attenzione al tema del perdono. Per questo al capitolo 18 presenta Gesù che indica la necessità del confronto con il fratello che ha peccato, che ha commesso una colpa, e la necessità di ricomporre il dissidio all’interno della comunità. Qualora questo fratello rifiutasse di ricomporre questa unità, deve essere amato come un pubblicano o un peccatore, cioè un amore in perdita, come l’amore al nemico.
Chi è incapace di perdonare semina la morte all’interno della comunità.
Pietro dunque si avvicina a Gesù e gli chiede: “Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette (numero di pienezza e totalità) volte?”. Domanda comprensibile: si può perdonare senza tenere conto del numero di volte in cui il perdono viene rinnovato? Se uno continua a compiere lo stesso male contro di me, fino a quante volte posso perdonarlo? Certamente Pietro non dimentica che nella Torah sta scritto che Lamech, il sanguinario figlio di Caino, canta la ripetizione della vendetta fino a sette e poi fino a settanta volte sette (cf. Gen 4,23-24). Pietro è già misericordioso, perché in verità non è facile perdonare sette volte lo stesso peccato allo stesso offensore. Ma Gesù gli risponde con autorità: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”, cioè sempre, all’infinito! Senza se e senza ma, il discepolo di Gesù perdona senza calcolare il numero delle volte. Di fronte a una tale dichiarazione l’ascoltatore resta stupefatto, forse anche esterrefatto, perché non è facile né comprendere né assumere questo atteggiamento.
La parabola non ha paralleli negli altri Vangeli e si trova solo nell’evangelo di Matteo. Si articola in quattro scene. Le prime due sono simmetriche, e mettono in evidenza il contrasto tra il diverso comportamento dei due creditori; la terza pone in risalto l’atteggiamento degli altri servi che notano il comportamento senza pietà del servo appena condonato, mentre l’ultima scena descrive il castigo comminato al servo spietato.
La situazione di partenza è simile nelle due scene parallele: un debitore, che non era in grado di rispondere dei propri debiti, secondo la legge del tempo poteva essere condannato al carcere. Nel caso in questione entrambi i debitori vengono condannati ed entrambi implorano misericordia. La loro richiesta è formulata con le stesse parole, ma con esito opposto: nella prima scena il debito viene cancellato, nella seconda invece no.
La parabola forza persino in maniera esagerata il contrasto presente tra i due debitori, sottolineando l’enorme sproporzione tra le due cifre da saldare. La prima è
astronomica, ed è troppo alta anche per un re; la seconda, invece, è piccola anche per un semplice servo. In questo modo si esalta ancora di più la generosità del re e si sottolinea l’ostinazione spietata del servo.
Contribuisce inoltre a dare un maggiore effetto anche il poco lasso di tempo che intercorre tra le due scene. “Appena uscito” dalla casa del re, ci si aspetterebbe che dalla gioia ancora viva dallo scampato pericolo, corrispondano sentimenti di benevolenza verso gli altri. Invece non è così, e ciò porta il protagonista a ritrovarsi nuovamente davanti al re, per sentirsi dire che l’annullamento della condanna è stato a sua volta annullato: il debito è ripristinato e la legge deve fare il suo corso. Ci ritroviamo al punto di partenza, con la differenza che la conclusione tragica prima evitata ora è messa in atto. Qualcosa ha rovinato tutto. Il re, che prima aveva perdonato, ora non è più disposto a perdonare, e questo perché, come spiega il re stesso: “Dovevi perdonare anche tu come io ho perdonato a te”.
Fin qui la parabola, abbastanza immediata nella sua vivace dinamicità.
Ma il testo, meditato con pazienza, può scavare dentro di noi e interrogarci, noi
uomini del XXI secolo, sul senso e sul significato del perdono.
Il perdono è centrale nella vita del cristiano.
La storia di Israele stessa nell’AT è la storia di una esperienza di peccato, a livello sia collettivo (il vitello d’oro!), sia individuale (pensiamo all’adulterio e all’omicidio compiuto dal re Davide).
E’ la storia di un’esperienza di ira e castigo divino (si pensi all’esilio di Babilonia). Ma alla fine, è un’esperienza di perdono, perché il Dio che Israele ha conosciuto nella sua tormentata storia è un Dio – come recita il Salmo 103 – «pietoso e clemente, lento all’ira e ricco di bontà… Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, e non ci castiga secondo le nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l’oriente dall’occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe».
La stessa esperienza l’ha fatta e continua a farla oggi la Chiesa. Essa stessa è il frutto del perdono dei peccati. Se non ci fosse il perdono, non ci sarebbe la Chiesa, che è la comunità dei peccatori perdonati. La storia della salvezza, che percorre tutta la Bibbia e giunge fino a noi, è la storia del perdono di Dio, che cancella il peccato risparmiando il peccatore. E questo perdono ha delle caratteristiche molto particolari in questo testo, che ho provato a sintetizzare così:
- è un perdono senza limiti
- è un perdono per tutti
- è un perdono che richiede a noi di fare altrettanto
- è una offerta di libertà
- è un atto di fede.
Innanzitutto, come detto, è un perdono senza limiti.Se ci pensate, la domanda iniziale di Pietro, “Signore quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me?”, non è solo un generico quesito posto a Gesù su quante volte lui dovrà perdonare il fratello che pecca. Pietro pone una domanda concretissima: il fratello ha peccato “contro di lui”, dice il testo, cioè sono stati violati quelli che noi oggi chiameremmo in termini moderni i suoi diritti personali.
E la risposta di Gesù: “Fino a settanta volte sette”, espressione semitica che indica, come sappiamo, senza limiti, sottolinea la misura sconfinata del perdono, e ci lascia intravedere anche il significato profondo della riconciliazione cristiana: non si tratta di un perdono singolo, offerto ad una singola offesa.
Cristo non ci chiede solo di perdonare le singole offese, ma di fronte alla rivendicazione inflessibile dei nostri diritti violati ci chiede di essere in primo luogo uomini di riconciliazione.
Il perdono cristiano coincide quindi con l’accettazione incondizionata degli altri, perché il perdono illimitato, richiesto da Cristo ai suoi discepoli, non è un perdono che si dà alla singola offesa, bensì un perdono anteriore a ogni possibile offesa, che
consiste appunto nell’accettazione del prossimo nelle sue diversità, nelle sue caratteristiche peculiari, nei suoi sbagli, nelle sue molteplici forme di immaturità.
Il senso profondo della riconciliazione cristiana consiste nella capacità di perdonare al nostro prossimo il peccato più grave che siamo soliti rimproverargli: quello di non essere come noi lo vorremmo. L’accettazione incondizionata degli altri è la misura, senza misura, indicata da Cristo a proposito del perdono.
Secondo punto: come dicevo, è un perdono “per tutti”. Il versetto iniziale della parabola recita “…il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi”.
Il mistero del Regno viene presentato come un giudizio, giudizio in cui sono convocati tutti i servi, non solo quelli che gli sono debitori; questa omissione ci porta a identificare la condizione di servo con la condizione del debitore. Essere servi è dunque lo stesso che essere debitori, ossia essere uomini è lo stesso che essere peccatori, e quindi necessariamente bisognosi del perdono di Dio; Dio ci chiama a libertà sottolineando con forza il nostro bisogno di essere accolti e perdonati da Lui.
La buona notizia per tutti gli uomini, ed anche per noi oggi, è questa: il peccato può essere cancellato; “il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito” L’Evangelo in fondo è proprio questa notizia: il peccato è stato cancellato da Gesù sulla croce. Come dice Paolo ai Romani: “tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù”.
La nostra piccola e fragile esperienza di Dio si fonda sull’esperienza che abbiamo del perdono. L’esperienza del perdono e l’esperienza di Dio, in fondo, coincidono. «Beato l’uomo a cui la trasgressione è perdonata, e il cui peccato è coperto!» recita il Salmo 32. Certo, molti negano che esista il peccato, e negando il peccato, negano pure la necessità del perdono, di cui non ne capiscono il senso. E dove il perdono svanisce, anche Dio diventa evanescente e presto scompare del tutto. Là dove invece, misurando la nostra umanità su quella di Gesù, prendiamo coscienza del nostro
peccato, là c’è la ricerca e l’attesa del perdono, e, ricevendolo, si sperimenta la beatitudine narrata un giorno da Gesù sul monte.
Ma Gesù va persino oltre, sconvolgendo le mie certezze, e mi dice: la richiesta di perdono che rivolgete a Dio è credibile se è accompagnata dalla disponibilità e dalla concreta pratica del perdono fraterno, come recita il Padre nostro: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. E ancora: “Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 6,14- 15).
Anche la liturgia giudaica afferma che nel giorno dell’espiazione e del perdono (Yom Kippur), vengono perdonati solo i peccati commessi contro Dio, mentre per le trasgressioni commesse tra uomo e uomo “lo Yom Kippur procura il perdono solo se uno prima si è rappacificato con il proprio fratello”.
Difatti il vero debito del servo è la mancanza di disponibilità a fare altrettanto con gli altri; il servo, cioè, non viene punito per l’enorme somma che non ha restituito al suo padrone, ma perché non lo ha imitato nella medesima generosità. E proprio Matteo ci ricorda che persino il criterio con cui saremo giudicati è in qualche maniera dipendente dalla misura che noi applichiamo agli altri nel giudicarli. “Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete condannati; perdonate, e vi sarà perdonato. Date, e vi sarà dato: vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi”.
Infine un ultimo particolare, per me il più inquietante. La parabola mostra che il perdono non necessariamente muta il cuore di colui che lo riceve.
E Gesù aggiunge: “«Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non condonerete»” – non è perdonare, ma condonare, l’iniziativa è del creditore – “«di cuore, ciascuno al proprio fratello»”.
Cosa significa il cuore? E’ frutto della nuova mentalità dove non prevale più la giustizia, ma la misericordia. Richiamandosi a quanto Gesù aveva detto in precedenza
sul legare e sciogliere, il significato è questo: il perdono del Padre verso gli uomini rimane legato finché non si scioglie il perdono ai fratelli. Dio ci ha già perdonato, ma questo perdono diventa operativo ed efficace soltanto quando si trasforma in perdono nei confronti degli altri.
La potenza e la grandezza del perdono stanno nella unilateralità con cui l’offeso non tiene conto dell’offesa ricevuta, ricrea le condizioni per la relazione con colui che lo ha offeso con un atto di totale gratuità, e accetta di veder rigettato e umiliato il suo gesto.
Il cristiano contempla il pieno dispiegarsi di questa unilateralità del perdono nel Cristo crocifisso.
Gesù è colui che, in modo asimmetrico, restaura la reciprocità, risponde all’odio con l’amore, offre il perdono a tutti, anche a chi non lo domanda. Questa unilateralità è la via scelta da Gesù Cristo per sconfiggere la mancanza di reciprocità di chi non riconosce il bisogno di perdono.
Lui ci offre questa possibilità, questa libertà: quella di perdonare gli altri, perché abbiamo sperimentato e sperimentiamo ogni giorno di essere stati perdonati da Dio. Ma rimane sempre aperta una possibilità: “Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?” Una domanda carica dello stupore di come possa verificarsi che, chi ha sperimentato tanto amore su di sé, non sia poi disponibile verso gli altri.
L’azione di Dio sta all’origine. Dio che per primo condona, usa misericordia e rende l’uomo capace di misericordia. Ma non è un colpo di spugna, il perdono di Dio non è mai un far finta che il peccato non ci sia, ma è un reale intervento per risolvere il problema: il perdono di Dio davvero trasforma la persona, la cambia dal di dentro e la abilita a fare qualcosa che non sarebbe in grado di fare da sola.
Attenzione al perdono a buon mercato, che non è quello di Dio e neppure quello del cristiano.
Termino con questa ultima sottolineatura: il perdono che Gesù ci offre interroga la nostra fede in lui. Le sue parole non sono – come spesso noi siamo soliti tradurle – un’indicazione di tendenza, un bel programma di vita, affascinante, ma sostanzialmente irrealizzabile, e neppure un dovere morale, un obbligo; sono una bella notizia, una beatitudine: noi possiamo essere misericordiosi, dal momento che Dio è misericordioso con noi.
Se ho fede veramente nel Dio rivelato nelle Scritture, se non mi sono fatto un Dio a mio uso, posso perdonare, che in definitiva significa affidare a Dio il mio risentimento e il mio desiderio di vendetta.
Infatti il finale della parabola ce lo ricorda: al re, e solo a lui, rimane il giudizio sul servo che non ha condonato il suo debitore; a Dio è lasciata l’ultima parola e il giudizio sull’uomo.
A noi invece viene proposta l’obbedienza a questa Parola: riconoscere di essere stati perdonati, e quindi, con la forza della fede nella sua Parola, credere per sola fede di poter perdonare, credere all’impossibile che Dio realizza in noi ogni giorno.
Gesù non si è limitato a comandarci di perdonare; lo ha fatto per primo. Mentre lo stavano inchiodando sulla croce egli pregò dicendo: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!”
Queste sono le parole più eroiche che mai siano state pronunciate sulla terra. Quelli si stavano accanendo contro di lui, straziavano la sua carne, e lui dice: “Padre, perdona loro”. Non solo li perdona, ma li scusa. Così facendo, Cristo non ci ha dato solo un esempio sublime di perdono, ci ha procurato una forza e una capacità nuova, che non viene dalla natura, ma dalla fede.
È ciò che distingue la fede cristiana da ogni altra religione.
Anche Budda ha lasciato ai suoi la massima: “Non è con il risentimento che si placa il risentimento; è con il non-risentimento che si placa il risentimento”.
Ma Cristo non si limita ad additare la via della perfezione; dà la forza per percorrerla. Non ci comanda solo di fare, ma fa con noi. L’apostolo Paolo ormai può dire: “Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi” (Colossesi 3:13).
È superata la legge del taglione: “Occhio per occhio, dente per dente”. Il criterio non è più: “Quello che l’altro ha fatto a te, tu fallo a lui”; ma è: “Quello che Dio ha fatto a te, tu fallo all’altro”. In questo, il perdono cristiano va al di là anche del principio della non-violenza o del non-risentimento. Questo vuol dire che dobbiamo andarci piano nell’esigere la pratica del perdono anche da persone che non condividono la nostra fede cristiana. Esso non scaturisce dalla legge naturale o dalla semplice ragione umana, ma dal Vangelo. Noi cristiani dovremmo preoccuparci di praticare noi il perdono, più che esigere che lo facciano gli altri. Dovremmo mostrare con i fatti che il perdono e la riconciliazione è, anche umanamente, la via più efficace per porre fine a certi conflitti. Più efficace di ogni vendetta e rappresaglia, perché spezza la catena dell’odio e della violenza, anziché aggiungere ad essa un nuovo anello.
Il servo, che il padrone considera maligno, non è capace di un piccolo perdono dopo averne ricevuto uno immenso. Questa incapacità di perdonare lo riporta alla schiavitù del suo vecchio debito.
Ogni volta che perdoniamo qualcuno, gli ridiamo vita e speranza. Ma è anche vero che nella nostra libertà possiamo anche dimenticare tutto questo e diventare duri di cuore, incapaci di perdonare e incapaci di dare vita al prossimo. Questo ci chiude in una prigione di cattiveria dalla quale rischiamo di non uscire più. Non solo “devo” perdonare, ma “ho bisogno” di perdonare, per attivare in me il perdono che a mia volta ho ricevuto e la speranza che mi è stata data.
Una comunità cristiana incapace di perdono reciproco diventa come una prigione dove i detenuti si fanno la guerra reciproca e diventa mortale. Lo stesso è per quanto riguarda la vita di coppia, in famiglia, tra amici e colleghi.
Se non si sente il bisogno di perdonare, di ridare speranza, di colmare i torti ricevuti prendendo l’iniziativa per primi, allora alla fine perdiamo tutti, sapendo che nel perdono che darò al mio prossimo, ritroverò tutta la forza e la salvezza del perdono ricevuto!