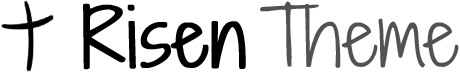Marco 2:1-12
Gesù guarisce un paralitico =(Mt 9:1-8; Lu 5:17-26)
Vorrei condividere con voi, quello che ho soprannominato “Quattro passi col paralitico”. Ci muoviamo a partire dalla Parola. Ognuno dei passi si articolerà prendendo le mosse dal racconto che troviamo al capitolo 2 del vangelo di Marco: la guarigione del paralitico. È un miracolo frutto anche di una grande opera di collaborazione. Per ognuno dei “passi”, cercheremo insieme di capire cosa vuole dirci il vangelo nell’ottica della collaborazione. Di per sé il paralitico non cammina, e qui sta il bello. E ho pensato un po’ a noi e alla collaborazione tra fratelli. Forse nel campo della collaborazione siamo un po’ bloccati, facciamo fatica. Siamo cresciuti all’insegna dei vecchi proverbi: “Chi fa da sé fa per tre” e via discorrendo.
Insomma: stentiamo ad uscire dalla logica dei grandi solisti. Forse dobbiamo ripartire da quell’ “A due a due” così caro alla vita e alla prassi di Gesù, dal primo invio in missione alla preparazione della Pasqua.
Troviamo Gesù nella città di Cafàrnao. Dal vangelo di Mt sappiamo che Gesù «lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare nel territorio di Zàbulon e di Nèftali» (Mt 4:12). Gesù emigra perché Nàzaret è chiusa tra le montagna ed è tagliata fuori dalle vie di comunicazione. Cafàrnao, invece, è una città situata lungo la grande arteria che dall’Egitto arriva fino a Damasco: l’incontro, il rapporto fisico tra le persone, misurarsi lo sguardo e le reazioni sono momenti essenziali anzi propedeutici all’incontro con Dio. Non può esserci incontro con Dio trascendente, al di fuori dell’immanenza della storia e della relazione tra gli uomini. La fede non è astrazione, ma incontro, comunicazione, interscambio.
Nello stesso tempo Cafàrnao è una città distante dai centri urbani come Tiberiade, capitale del regno di Erode Antìpa. Gesù se ne stava defilato per compiere più tranquillamente la sua missione di rabbi itinerante senza richiamare troppo l’attenzione del potere politico che era colluso con quello religioso. Cafàrnao è una città cosmopolita e aperta, un laboratorio d’incontro e di tolleranza. Da Cafàrnao proviene la prima comunità apostolica con i primi discepoli, specialmente Pietro.
Primo passo. Radunati dalla Parola
-
Il vangelo
[1] Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa [2] e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. [Mc 2, 1-2]
È questo il primo dato, semplicissimo, che il testo di Marco ci propone di contemplare: la parola raduna, raccoglie.
Fa Gesù per primo ciò che chiederà poi di fare ai suoi discepoli: entrare nelle case per portare la pace, la guarigione, per porre segni credibili e consolanti del Regno di Dio già presente in mezzo a noi. Per lasciare un messaggio di grande speranza: i tuoi peccati sono perdonati. Non concepisce se stesso in un ruolo sacrale, non pensa neppure per un istante di avere assolutamente bisogno di una cattedra, di una sinagoga, di un tempio per poter dire il Vangelo.
Va benissimo una casa, una casa qualunque. Ma non un luogo chiuso, difeso, troppo protetto.
E ci sorprende vedere come la casa abbia bisogno di essere scoperchiata, aperta: la forza della parola non conosce mura o tetti in grado di contenerla. La parola corre, viaggia: se da una parte cerca uno spazio raccolto per poter essere annunciata con cura e accolta a cuore aperto, dall’altra non si lascia imprigionare, confinare in un appartamento, in un luogo appartato, sigillato: piuttosto “sprigiona” una forza dirompente, apre uno spazio in cui lo Spirito, dall’alto, possa scendere e guarire.
Secondo passo. Il miracolo della collaborazione
-
Il vangelo
[3] Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. [4] Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. [5] Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati”. [Mc 2, 3-5]
Più che al paralitico vorremmo guardare alla splendida figura dei suoi amici, questi misteriosi portatori che lo conducono con premura, ingegno, coraggio, davanti al Signore.
I portatori del paralitico, nel brano di Marco, diventano l’immagine di chi porta Gesù e di chi porta a Gesù.
Ci chiediamo: come agiscono i barellieri di Marco, nel loro portare al Signore mentre sostengono il peso della malattia, della paralisi, della ferita aperta di quest’uomo? Occorre dire anzitutto che i barellieri sono quattro. Sono un’équipe. Nessuno di loro da solo ce l’avrebbe fatta. Non è semplice portare una barella sul tetto, calarla nella casa senza fare danni alle cose o – peggio – al malato stesso. I portatori, ed è una seconda annotazione, sono uomini, uomini normali. Non sono neppure discepoli: è gente comune. Rimangono anonimi: così come sono entrati in scena all’improvviso, spariscono e non compaiono più per il resto del vangelo. Anche di loro, come di molti personaggi cosiddetti “minori”, si perdono le tracce. Marco non dedica loro più di tre versetti. È interessante notare come spesso nei vangeli i personaggi migliori spariscano subito (i portatori, la vedova che offre le due monete nel tempio, la donna sirofenicia di cui Gesù loda la fede… e l’elenco si potrebbe allungare) mentre restino a lungo sulla scena personaggi sicuramente meno edificanti: i discepoli che non capiscono, gli scribi e i farisei con l’ingombro delle loro parole e dei loro pensieri, Erode con la sua ricerca mancata e poco credibile del volto di Gesù…
Colpisce, tornando ai nostri portatori, il loro assoluto anonimato: neanche una menzione d’onore, un applauso, un complimento. Il vangelo non riporta una sola parola di questi umili barellieri, eppure pochi altri in tutta la Scrittura (santi apostoli compresi) sono stati capaci come loro di portare a Gesù, di condurre a lui, di permettere ad un malato di incontrare il Signore e di trovare guarigione e perdono. Non si fa tutto questo senza una profonda passione, senza un affetto vero. Se fossero stati degli estranei, degli sconosciuti, o peggio ancora dei “professionisti” regolarmente pagati, si sarebbero piegati di fronte alle difficoltà, avrebbero messo il paralitico davanti all’evidenza dei fatti. Ed è a questo punto che il vangelo ci regala una sorpresa inattesa. Ce la regala – come spesso capita – sottovoce, attraverso un inciso, con delle parole che potrebbero perfino essere tolte dal brano senza snaturarne la lettura o la struttura dell’analisi logica. Siamo al v 5: “Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico…”. Vista la “loro” fede. Il Maestro non guarisce il paralitico a causa della sua fede, ma della fede dei suoi amici. Non si smuove perché intenerito dallo spettacolo dell’uomo malato, ma perché ammirato e sorpreso dalla forza della fede di coloro che l’hanno condotto da lui.
Se si vuole portare a Gesù, lo si può fare soltanto con amore. Non può essere un favore che ci viene quasi estorto, o che non si ha il coraggio di rifiutare. Può essere solo un amore, una passione. Per colui che si porta e per il Signore stesso. Se i portatori non avessero avuto una ferma fiducia nella possibilità di Gesù di fare qualcosa per quest’uomo, probabilmente non avrebbero fatto tutto questo per lui. Volevano bene al paralitico, ma si fidavano anche di Gesù: una fede forse ingenua, sicuramente imperfetta, magari molto primitiva ci verrebbe da dire, ma non per questo meno vera.
Anche questo dice qualcosa rispetto alle nostre fatiche nella collaborazione. A volte a mancare sono l’affetto e la stima reciproca. E questo è un bel guaio. Soprattutto nei momenti difficili occorre ritrovare la stima, rinnovare lo sguardo: è un passo previo alla collaborazione “operativa” che a volte ci si dimentica di fare: quando la presenza dell’altro è data per scontata o è mal sopportata ogni forma di cooperazione sensata diventa impossibile. Eppure è veramente la fede degli altri a portarci, soprattutto nei momenti in cui i nostri peccati, la nostra negligenza, la nostra stanchezza, paralizzano le capacità di agire, di pregare, di operare il bene, di porre rimedio ai nostri errori. La fede degli altri ci sostiene ad es. quando qualcuno semplicemente ci promette che pregherà per noi. Sono molte le tentazioni “contro” la collaborazione. Ne ricordiamo solo due. Una prima può essere identificata dalla fretta: quando un progetto è più importante delle persone, spesso apparentemente si ottengono grandi risultati; in realtà si perde di vista l’essenziale. Dobbiamo accettare la lentezza dei tempi se vogliamo che sia rispettato il cammino di ciascuno. L’obiettivo che perseguiamo non può essere quantificato in termini produttivi. Una seconda tentazione è legata alla paralisi, ai blocchi che ciascuno di noi si porta dentro: il giudizio sulle persone, il cinismo col quale liquidiamo una situazione “perché tanto non c’è niente da fare”, i malintesi che non si ha il coraggio di chiarire, la paura di esporsi… e potremmo andare avanti di questo passo ad elencare le mille paure che non ci permettono di rischiare, che ci impediscono anche qualche errore salutare.
Terzo passo. Ostacoli, cadute, salite
-
Il vangelo
[6] Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: [7] “Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?”. [8] Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: “Perché pensate così nei vostri cuori? [9] Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? [Mc 2, 6-9]
Il testo di Marco ci mette di fronte come a due paralisi: quella dell’uomo portato sul lettuccio e quella degli scribi che assistono alla sua guarigione, ma prima ancora, che ascoltano le parole sconcertanti di Gesù: “ti sono rimessi i tuoi peccati”.
Il paralitico, anzitutto. Gli esegeti fanno notare la sua assoluta passività: non solo non è in grado di muoversi, ma neppure dice una sola parola, nemmeno quando – ormai guarito – si fa carico del proprio letto e torna a casa sua. Quando Gesù parla con lui non risponde; non manifesta alcuna sorpresa di fronte alle parole difficili da comprendere: “ti sono rimessi i peccati”. È comunque – come lo sono spesso i malati ritratti nei vangeli – un uomo che porta in sé i segni del fallimento della sconfitta: l’uomo è fatto per il movimento, il corpo è fatto per muoversi, non per rimanere fermo, bloccato.
Anche sul versante simbolico, la paralisi designa l’incapacità a raggiungere le mete prefisse, i risultati desiderati. Si è sempre nelle mani di qualcun altro, non si è autonomi, non si è in grado di fare molte cose da soli. È una condizione difficile da accogliere, da accettare.
La figura del paralitico evoca dunque un’umanità rassegnata al male, incapace di uscire dall’infelicità della propria complessiva situazione, distante da quella “immagine e somiglianza di Dio” di cui parla il libro della creazione.
Ma nel testo di Marco non c’è spazio soltanto per la paralisi dell’uomo che giace sul lettuccio: c’è un’altra, ben più grave incapacità a muoversi, ad uscire da una situazione di fallimento e di tradimento rispetto all’originaria vocazione dell’uomo che è quella che vivono gli scribi presenti nella casa dove Gesù sta annunciando la parola.
Stanno seduti, anzitutto, in una posizione che dovrebbe essere quella dell’ascolto, ma che nella logica di Marco esprime piuttosto l’atteggiamento di chi non vuole più camminare, non se la sente più di muoversi. Né più né meno che il paralitico, verrebbe da dire.
E poi non hanno il coraggio di intervenire ad alta voce, di esprimere il loro parere, di alzarsi in piedi, appunto, per manifestare il loro sdegno, la loro irritazione. Preferiscono ragionare tra sé e sé, rimuginare tra loro in un’inespressa ma realissima mormorazione che non produce nessun risultato tangibile, nessun cambiamento, che non ha nemmeno il merito di evidenziare un comprensibile disagio di fronte alla provocazione lanciata dalle parole forti di Gesù. Anche loro, come il paralitico, non pronunciano ad alta voce nessuna parola, restano chiusi nel loro mutismo, non entrano in una reale relazione col Signore. E non sono neppure guariti, a differenza dell’uomo che giaceva sul lettuccio, perché troppo convinti di essere dalla parte del giusto, del vero.
Quarto passo. Tornare a casa
-
Il vangelo
[10] Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, [11] ti ordino – disse al paralitico – alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua”. [12] Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: “Non abbiamo mai visto nulla di simile!”. [Mc 2, 10-12]
Sorprendono le parole finali, quelle con cui Gesù guarisce e congeda il paralitico: “prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua”. Eppure sono parole decisive.
Il letto per chi vive una vita normale è il luogo del riposo, della sosta, in cui finalmente si placano le ansie e le fatiche della giornata e il corpo riprende forza e vita.
Per il paralitico è il carcere, è il luogo della condanna, che gli rivela in maniera cruda e incontrovertibile la radicalità, la non-guaribilità della malattia, l’impossibilità ad uscirne. Al paralitico guarito questo lettuccio, questa barella, di per sé non servirebbe più. Non ne ha più bisogno, ora può farne a meno.
Eppure Gesù gli dice di portarla con sé. Quest’uomo si dovrà sempre ricordare la grazia di cui è stato fatto oggetto. Si dovrà ricordare per tutta la vita di essere un peccatore perdonato, di avere incontrato un Signore che ha guarito la sua malattia, che l’ha rimesso in piedi. Il lettuccio che si porta a casa glielo ricorderà: sarà lì a raccontare di un passato dal quale solo per grazia è riuscito ad uscire; lo aiuterà a vivere nella gratitudine per il dono ricevuto, nella memoria del miracolo che gli ha cambiato la vita.
Quest’uomo viene rimandato a casa, dai suoi. È lì che dovrà essere testimone della gioia della guarigione e della buona notizia del perdono. Esce dalla casa dove Gesù si trova a predicare il vangelo per diventare lui stesso in un’altra casa un vangelo vivo, un segno credibile e visibile della buona notizia della misericordia. La sua casa è il luogo dove può dire che Dio gli ha voluto bene, il luogo dove può tornare a vivere da uomo compiuto, perché la misericordia di Dio l’ha inaspettatamente raggiunto e trasformato. Gesù non l’ha guarito per farne un discepolo, per portarlo con sé sulle strade della Palestina, ma perché nella sua casa, tra i suoi, quest’uomo possa testimoniare la gioia del perdono, perché un’altra casa possa diventare casa dove risuona la Parola.
Tornare a casa è sentirsi a casa. Spesso collaborare significa semplicemente “fare bene la propria parte”. Se ci pensiamo è un bel modo di dire: significa che la propria è solo una parte, non è il tutto. Per trovare senso e valore, compiutezza e pienezza ha bisogno anche della parte dell’altro. Di più: fare la propria parte è il modo concreto di “sentirsi parte”, di vivere nel poco e nel frammento il proprio legame con il tutto. Tornare a casa è crescere nel bene. La collaborazione non è soltanto un fatto tecnico. Molta della nostra capacità di collaborare si gioca innanzitutto nella disposizione ad accogliere e a ricevere, nell’umiltà di scoprirsi fragili e poveri, bisognosi di tutto. Senza nessuna paura. Riconoscere di non bastare a noi stessi ci fa bene: è un ottimo punto di partenza. Da qui si comincia; al resto ci pensa il Signore.